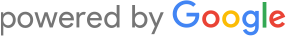I fari più belli e suggestivi d’Italia
8 minuti

“Guardavano le dune lontane, e invece di gaiezza sentivano calare sull’animo una vaga malinconia […] parte perché il remoto paesaggio sembrava dover sopravvivere per migliaia e migliaia d’anni allo spettatore, esser già in comunione con un cielo contemplante una terra in estremo riposo.”
La signora Ramsey e William Bankes di “Gita al faro”, romanzo di Virginia Woolf, provano questa sorta di spleen guardando le onde dalla baia. Una malinconia che si specchia nei semicerchi disegnati dalle barche sul mare, parte di un paesaggio immortale, riflesso negli occhi di creature mortali. Così, guardando l’acqua, accecante di giorno e un pozzo scuro di notte, i fari hanno il potere di scatenare negli spettatori sensazioni che nel caos della città sono spesso sopite. I fari sono poesia, mistero, verticali e imponenti punti esclamativi su quel lunghissimo flusso di coscienza che è il mare.
Non a caso la letteratura ha da sempre dedicato ampi spazi ai fari, a partire da autrici celeberrime quali, appunto, Virginia Woolf, per arrivare a contemporanei scrittori di libri per ragazzi come Pierdomenico Baccalario, con la serie di romanzi fantasy di “Ulysses Moore”.
Non occorre essere dotati di un’anima marinara per apprezzare questi giganti ciclopi solitari, basta saperli ascoltare. Molti racchiudono storie particolari, antiche, altri restituiscono voci lontane di marinai, altri ancora sono più laconici, perché ormai l’unica lingua che conoscono è quella dell’acqua salmastra.
Per voi, amanti dei fari e dei misteri, un itinerario che vi porterà in tutta Italia, da nord a sud e poi sulle isole, per chiedere a questi lanternoni cos’hanno di speciale da raccontare. Partirete da una Trieste gloriosa, con la Vittoria alata svettante sul Golfo; il battere delle sue ali vi sospingerà più in basso verso Genova, capitana con la sua Lanterna, che è il faro più alto del Mediterraneo e il secondo in Europa.
In Toscana si fa visita al faro di Livorno e a quello di Capel Rosso, sull’Isola del Giglio, e ancora più giù, in Campania, ad Anacapri, con il faro di Punta Carena e in Puglia con i fari di Punta Palascìa a Capo d’Otranto e quello di Santa Maria di Leuca. Da qui, non vi restano che le isole: la Sicilia, con la sua isola nell’isola, Strombolicchio, e la Sardegna, con i fari di Capo Spartivento e il Mangiabarche.
Il Faro della Vittoria a Trieste

Il primo faro di questo viaggio è il faro della Vittoria di Trieste, così chiamato per via della Nike alata che, bronzea, svetta dai suoi 70 metri di altezza con una fiaccola nella mano sinistra e una corona d’alloro nella destra. La statua guarda il Golfo di Trieste, sbattendo le sue ali grazie al meccanismo racchiuso al suo interno, e ricorda il momento e le ragioni della sua fondazione.
Il monumento nasce, infatti, dopo la Grande Guerra su un progetto dell’architetto Arduino Berlam: si voleva un faro nuovo, che simboleggiasse il vento di cambiamento e portasse, appunto, nuova luce. Il faro della Vittoria rappresenta non solo il passaggio della città al Regno d’Italia, ma anche commemora i caduti in mare durante il conflitto, come fa pure l’incisione dannunziana sul basamento: “Splendi e ricorda i caduti sul mare”.
Ma il faro vi parlerà anche del Marinaio Ignoto presente poco sopra il basamento. La sua statua alta circa 8 metri rappresenta un uomo di mare con il classico copricapo della Regia Marina e stivali da lavoro. Scruta l’orizzonte come a cercare la sua barca o un amore lontano.
L’ultima informazione che il faro della Vittoria vuole darvi sta in un’ancora posta poco sotto quest’ultima statua. Si tratta dell’ancora dall’Audace, la prima barca italiana ad approdare a Trieste, corredata dall’epigrafe “Fatta prima d’ogni altra sacra dalle acque della gemma redenta, il 3 novembre 1918”.
La Lanterna di Genova

Dal nord est della Penisola al nord ovest: Genova. Quando si pensa a questa città sicuramente vengono in mente S. Giorgio e il drago e la croce rossa in campo bianco, ma bisogna sapere che vi è un altro importante simbolo: il fanale di Capo di Faro, chiamato Lanterna di Genova. Un motivo di orgoglio per i genovesi, perché si tratta del faro più alto del Mediterraneo e il secondo in Europa. Non vi resta che lasciarvi affascinare dalla sua storia.
La prima torre risale a tempi antichi, al 1128, quando per segnalare le navi in avvicinamento si usava bruciare fasci di steli secchi di “brugo e brusca” (erica e ginestra). Nei primi anni del 1300 la torre fu testimone della contesa tra Guelfi e Ghibellini e ne rimase offesa, così venne aggiunto un fossato per renderla più difendibile. La povera Lanterna, nel 1326 fu illuminata per la prima volta ad olio di oliva, l’annalista Giorgio Stella scriveva: “In quest’anno fu fatta una grande lanterna sulla torre di Capo Faro affinché con le lampade in essa accese, nelle notti oscure, i naviganti conoscessero l’adito alla nostra città”.
Dopo altri bombardamenti, nel XVII secolo finalmente il faro di Genova venne fortificato a dovere, e oggi che non corre più rischi può finalmente rivendicare la sua imponenza: 77 metri di altezza e una luce dalla potenza notevole che raggiunge i 50 km di distanza.
I fari toscani di Livorno e del Giglio

Poche ore di macchina separano Genova da Livorno, dove vi aspetta la visita al fanale di Livorno ancor più antico della Lanterna e la cui storia, comunque, si intreccia con quella di Genova. Perché il faro livornese fu costruito come simbolo di rinascita dalla Repubblica Marinara di Pisa dopo la sconfitta contro i genovesi nella battaglia della Meloria del 1284.
Da qui, scendete ancora verso sud, e da Porto Santo Stefano, al Monte Argentario, prendete un traghetto per l’isola del Giglio. Qua troverete il bellissimo faro Capel Rosso con la sua divisa a strisce bianche e rosse, oggi trasformato in un relais che offre riposo con vista sull’orizzonte verde e blu.
Faro di Punta Carena ad Anacapri

La tappa successiva al faro dell’isola del Giglio è la lontana Punta Carena, ad Anacapri. Se chiedete agli abitanti della zona qual è la loro spiaggia preferita, vi risponderanno che è quella del faro. In realtà non è una vera e propria spiaggia, bensì un lido roccioso immerso in un silenzio riempito solo dallo scrosciare delle onde che si infrangono sulle rocce. Luogo di confine con il mare, come tutti i fari, il suo nome antico era Punta di Limmo, dal latino “limen”, cioè confine.
La costruzione di questa torre luminosa ebbe inizio nel 1862, anche se venne accesa solo nel periodo del regno borbonico e delle due Sicilie. Come il faro dell’isola del Giglio, il faro di Anacapri veste di bianco e rosso.
I fari pugliesi: da Punta Palascìa a S. Maria di Leuca

Ha un che di malinconico il faro di Punta Palascìa a Capo d’Otranto: una candida torre in pietra isolata nel punto più a est d’Italia.
Ha origini parigine, almeno nella sua lanterna, fabbricata dal pupillo di Gustave Eiffel. Ma è anche un simbolo d’unione fra Oriente e Occidente, gentil ricevitore della prima alba e orgoglioso portavoce della bellezza faunistica e floristica della zona con il suo Museo Multimediale del Mare. Si direbbe un luogo incantato tanto che, secondo alcune leggende, nelle notti in cui la tramontana soffia forte e le onde si infuriano in burrasca schiumosa, si sente un canto di sirene, emozionante e triste allo stesso tempo. Secondo altre credenze, si tratterebbe di voci di streghe che, nascoste nelle cavità delle rocce, bramano di portar via il primo malcapitato.
A circa un’ora di auto vi è un’altra meraviglia: il faro di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. È il faro più alto della Puglia e il secondo più alto d’Europa. Come il collega di Otranto, il faro di Leuca ha qualcosa di parigino: è a Parigi che la lanterna venne costruita, ed è dotata della lente di Fresnel, invenzione di un fisico francese che usò un sistema di prismi per riflettere e deviare le onde luminose.
Il faro di Strombolicchio in Sicilia

Lasciato il continente, si approda in Sicilia, in quell’arcipelago di isole magnifiche che sono le Eolie. In particolare, in quella magmatica di Strombolicchio: è ciò che rimane di manifestazioni vulcaniche del più antico vulcano delle isole Eolie. Raccontano le leggende che una volta Stromboli eruttò così forte che lanciò via il tappo che lo teneva a bada, il quale si catapultò nel mare delle Eolie a testa in giù: ecco Strombolicchio.
Sulla sommità dell’isolotto sorge, solitario, il suo faro. Per raggiungerlo bisogna salire una ripida scala di 152 gradini: i primi, intagliati nella roccia e lambiti dalle onde sono percorribili sono quando il mare è calmo. Attivo dal 1938, oggi il faro non ha più un guardiano a fargli compagnia, da quando è stato automatizzato ed è passato sotto il controllo della Marina Militare. L’ultimo compagno del faro di Strombolicchio è stato Luciano Rizzo, che ha salutato la torre bianca nel 2012 per andare in pensione e oggi ricorda aneddoti rischiosi ma al contempo divertenti, come quando occorreva riparare gli intoppi della lanterna e doveva recarsi di persona al faro sfidando il mare in tempesta e la scogliera.
Spartivento e Mangiabarche: fari di Sardegna

Altra isola, altri fari. In Sardegna vi aspettano due fari suggestivi tanto quanto i loro nomi: Spartivento e Mangiabarche.
Il primo, sull’omonimo promontorio in località Domus de Maria, è uno dei fari più antichi della Sardegna. Con la sua torre rossa è un faro d’altura, composto da un edificio di 19 metri, sulla quale poggia la struttura della lanterna rivestita dalla gabbia di Faraday, che isola l’ambiente interno da qualsiasi campo elettrostatico all’esterno. Oggi il faro è un hotel di lusso.
Il faro Mangiabarche si trova sullo scoglio omonimo al largo dell’isola di Sant’Antioco e provoca un brivido già a sentirlo nominare. In effetti il faro segnala ai naviganti la presenza di un tratto di mare particolarmente rischioso, con scogli e secche affioranti dal mare. Lo scrittore Massimo Carlotto ha dedicato allo scoglio addirittura un romanzo, scrivendo: “L’origine del nome era evidente: sembrava la dentatura di un mostro marino”. Non prendete sotto gamba, quindi, questo piccolo faro, o vi spalancherà le sue fauci…