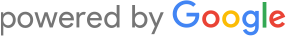Enotour estivo
7 minuti

I tramonti infuocati e la dolce atmosfera delle serate sotto il cielo stellato stanno già accarezzando le nostre giornate: è la magia dell’estate, uno dei momenti più belli dell’anno da vivere al meglio entrando in cantina e godendosi un’esperienza rilassante, immersa nel verde e lontano dal caos. Pic-nic e cene in vigna, musica dal vivo, escursioni in natura osservazioni astronomiche, balli di gruppo e momenti di folklore: queste e tante altre attività trasformeranno le cantine del Movimento Turismo del vino nei luoghi perfetti per sfuggire dalla routine e ripararsi dal caldo all’ombra dei vigneti. L’estate MTV è un momento da vivere lentamente, tra sapori e tradizioni da riscoprire, godendosi ogni minuto in compagnia dei produttori e brindando ai momenti insieme.
L’estate nelle cantine trentine alla scoperta degli Spätzle e Muller Thurgau

Tra le valli del Sudtirol, gli Spätzle sono uno dei grandi must a tavola. Pur essendo originari della regione della Svevia, in Germania, questi gnocchetti dalla forma irregolare iniziarono a diffondersi, a partire del medioevo, nei territori di confine circostanti. In base alla zona, gli spätzle cambiano forma e metodo di preparazione: da quelli arricchiti da abbondante formaggio e poi gratinati al forno a quelli alle erbe di montagna fino alla versione dolce tedesca con mele e cannella. In Trentino Alto Adige invece sono spesso bianchi e verdi, questi ultimi ottenuti con l’aggiunta al classico impasto di spinaci lessati. Si parte da una base di farina, uova, acqua e un pizzico di sale per ottenere un composto morbido che prenderà forma attraverso un particolare strumento. Si tratta dello spatzlehobel una sorta di grattugia dai fori larghi nel quale viene inserito l’impasto direttamente nella pentola di acqua bollente per creare questi piccoli gnocchetti che in pochi minuti salgono a galla e sono pronti per essere scolati. Un piatto genuino che sa di montagna spesso accompagnato da un condimento altrettanto semplice: di solito si saltano in padella con burro e salvia, nelle versioni più ricche si aggiunge panna fresca e speck. Nonostante le sue umili origini questa ricetta ha saputo conquistare i palati di diversi Paesi, dall’Austria e Svizzera fino all'Ungheria, tanto da meritarsi una giornata nazionale dedicata. Di solito serviti come primo piatto, gli spätzle possono anche essere usati come accompagnamento ai secondi di carne ed è proprio da qui che sembrerebbe derivare il loro nome. Spätzle, infatti, in tedesco significa “passerotto”, un termine probabilmente ispirato sia dalla forma sia dal loro essere usati come sostituto del pane in accompagnamento alla selvaggina.
La versione classica degli spätzle ben si abbina con la freschezza e la piacevole aromaticità del Muller Thurgau, nato nell’800 dall'incrocio tra Riesling e Madeleine Royale, un vitigno di origine francese. Da un lato un profilo aromatico fruttato che spazia dalla mela verde, agli agrumi fino alla pesca, al quale si aggiunge una piacevole nota erbacea, dall’altro un corpo fresco e leggero, che lo rende uno dei vini bianchi di montagna più adatti per l’estate. Le sue caratteristiche si sposano bene con il sapore degli spätzle, valorizzando la parte vegetale mentre la freschezza del vino bilancia la rotondità data dal burro. Un abbinamento da conoscere in cantina, mettendosi il grembiule e lasciandosi guidare nella preparazione di questa e tante altre ricette all’interno dei laboratori di cucina per poi passare alla degustazione dei vini dell’azienda. E dopo l’assaggio le cantine del Movimento Turismo del Vino organizzano tour in bicicletta, escursioni in montagna, visita negli ecomusei nonché mercatini tipici per conoscere l’artigianato locale e le piccole produzioni della zona.
Toc in braide e Friulano: i sapori di una tipica cena estiva in Friuli Venezia Giulia

La bassa friulana, terra di campi dorati e tradizioni autentiche, dove la vita contadina ha plasmato il paesaggio e continua a regalare grandi produzioni. Qui, infatti, i vini d’eccellenza si incontrano con una produzione di formaggi altrettanto degna di nota. E’ il Montasio il principe tra tutti, un formaggio di latte vaccino a pasta semicotta con una stagionatura minima di 60 giorni che si protrae fino a oltre un anno per le versioni più di struttura. Con il suo aroma dolce e delicato e la sua pasta compatta il Montasio è davvero versatile, capace di conquistare già da solo in un tagliere, ma che dà una delle sue migliori espressioni all’interno di una delle ricette più iconiche delle case friulane. Il Toc in Braide, semplice ma gustoso, è il piatto per eccellenza della cucina contadina di montagna: si tratta infatti di una polenta abbastanza morbida abbinata a una fonduta di formaggio, che funge da companatico. Letteralmente “intingolo nel podere”, questo piatto richiama la coltivazione di mais che interessa queste zone già a partire già dal XVIII secolo quando la polenta divenne il principale alimento di sussistenza della popolazione locale. Per preparare il condimento si sciolgono i formaggi a bagnomaria con l’aggiunta di latte fino ad ottenere una crema densa che ricoprirà poi la polenta e, per completare il piatto, si aggiunge il “morcje”, ovvero un intingolo di burro di malga e farina di polenta che riviste l’ultimo strato, da passare in forno per ottenere una crosticina croccante. Data la sua consistenza scioglievole e il suo sapore di carattere, il Montasio è diventato uno dei formaggi prescelti per questa ricetta, ancora oggi usato sia in casa che nelle versioni più gourmet.
Nelle cantine del Movimento Turismo del Vino si possono assaggiare questa e tante altre ricette realizzate con prodotti locali e di stagione. Ma le cantine del Friuli offrono anche la possibilità di trascorrere tanto tempo all’aria aperta tra escursioni, passeggiate in vigna tra le sculture e le installazioni temporanee, concerti in campagna con gli artisti della zona, degustazioni di formaggi di malga e delle altre eccellenze del territorio. Il Toc in Braide, piatto che abbraccia tutta la regione, dalla Carnia fino a Udine, non poteva non incontrare in abbinamento il vino bandiera di questa terra, il Friulano. Conosciuto all’inizio come Tocai, questo vino di grande complessità ed eleganza ha perso il nome ma non il suo carattere unico con un profilo sensoriale dai fiori bianchi, alle erbe aromatiche fino a un tocco di agrumato e alla leggera nota di nocciola nelle versioni più evolute. Un vitigno dalle mille personalità che, in base alla zona di produzione, riesce a sviluppare sfumature sempre nuove: se nel Collio dà vini più strutturati e minerali, nella bassa friulana si esprime con una freschezza che amplifica la rotondità del Toc in Braide regalando un equilibrio armonioso che esalta i sentori del formaggio a ogni boccone.
L’estate a tavola con le Sarde in saor e i vini dell’entroterra veneziano

Siamo cuore della laguna veneziana per conoscere una ricetta figlia del mare: sono le Sarde in saor, uno dei piatti più identitari della regione che affonda le sue radici nel 1300 quando la Repubblica di Venezia divenne sempre più il fulcro delle principali rotte commerciali. Un piatto nato dall’ingegno e dal bisogno dei pescatori di conservare il pescato durante le lunghe traversate, che unisce i tipici sapori della laguna all’agrodolce, testimonianza del forte legame che la Serenissima aveva costruito con le culture del Mediterraneo e dell’Oriente. Tradizionalmente preparate con cipolla, appassita in padella insieme a olio e aceto, le sarde in saor, nei secoli, hanno avuto un’evoluzione nella loro preparazione, diventando una ricetta sempre più elaborata. Il saor, ovvero l’intingolo aromatico che dà il carattere a questa ricetta, si è arricchito con l’aggiunta di uva sultanina e pinoli che conferiscono le particolari note dolciastre capaci di raccontare in un solo assaggio le numerose influenze culturali che, nei secoli, hanno interessato la laguna veneziana. Le sarde vengono prima fritte, poi immerse e lasciate riposare nel saor, così da creare un insieme di sapori che si gioca tutto sull’equilibrio tra dolce e salato. E’ una ricetta che dà il meglio di sé soprattutto dopo qualche giorno dalla sua preparazione: le sarde in saor, grazie all’aceto, uno dei più antichi metodi di conservazione, si mantengono in frigo fino a una settimana, sprigionando un’esplosione di sapori sempre più intensa. Un piatto semplice ma fortemente caratteristico che rispetta la stagionalità della pesca: tradizione vuole che venga preparato a partire dal periodo estivo all’inizio dell’autunno, mesi in cui le sarde raggiungono le coste veneziane.
Per il suo sapore forte e intenso, le sarde in saor possono essere affiancate a due vini dell’entroterra veneziano: da una parte c’è il Raboso, autoctono delle rive del Piave, chiamato anche vin del sangue per il suo colore rubino intenso e vibrante. Sincero e di carattere si esprime con sentori di marasca e spezie, un tannino deciso e una spiccata acidità che da un lato smorza la frittura delle sarde e dall’altro si incontra alla perfezione con l’agrodolce del saor. Ideale anche l’abbinamento con il Lison nato nell’omonima zona Lison-Pramaggiore, terra di confine tra la laguna veneta e il Friuli-Venezia Giulia. E’ proprio dal vitigno Friulano che ha origine questo vino dal profilo delicato e floreale, con sentori di mela verde e mandorla e una vena sapida che lo rende un abbinamento armonioso con le sarde. Due varianti da provare entrando nelle cantine del Movimento Turismo del Vino della regione e lasciandosi guidare dai produttori durante il percorso di degustazione. Tra aperitivi al tramonto e vista mare, pic-nic in vigna cene a tema si possono scoprire i vini delle aziende e assaggiare i prodotti negli agriturismi, con visite negli orti e nelle fattorie didattiche per un’esperienza adatta a tutte le età.