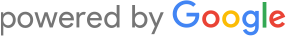Marmi e colonne sul fondo del mare: tra i relitti delle navi lapidarie
5 minuti

Tra i relitti antichi conservati sui fondali marini, quelli delle cosiddette naves lapidariae colpiscono l’immaginazione e raccontano una storia unica e di grande fascino: il trasporto marittimo a lungo raggio dei materiali da costruzione. Nel mondo antico, i materiali da costruzione potevano viaggiare da un estremo all’altro del Mediterraneo: i marmi pregiati raggiungevano Roma dalle isole della Grecia, dalle cave dell’Asia Minore e dai giacimenti del Nord Africa. Lo stesso accadeva anche per materiali già sbozzati e semilavorati come colonne e sarcofagi, che erano imbarcati su navi spesso appositamente realizzate e rinforzate, le naves lapidariae, appunto, e diretti poi verso porti specializzati, dove un’area specifica, la statio marmorum, disponeva di gru e argani per lo scarico di oggetti così pesanti. Questi imponenti traffici si possono ricostruire analizzando la provenienza dei materiali giunti a destinazione, ma anche grazie alla conservazione, sul fondo del mare, delle tracce di naufragi di alcune navi lapidarie. I legni di queste imponenti imbarcazioni sono quasi sempre perduti, ma i carichi, i blocchi, le colonne, i sarcofagi, le macine, resistono per secoli sui fondali, colonizzati dalla vita marina ma ancora perfettamente riconoscibili. Anche nelle AMP italiane si conservano alcuni di questi singolari relitti.
Le colonne di Torre Chianca
Uno dei luoghi più incantevoli d’Italia in cui è possibile ammirare un antico carico lapideo in mare si trova in Puglia, nell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo: all’ombra della Torre Chianca, a meno di 5 metri di profondità nel mare cristallino del Salento, cinque colonne monolitiche, individuate già negli anni Sessanta del XX secolo, raccontano a subacquei e turisti in snorkeling un naufragio avvenuto nel II secolo d.C.
Le colonne, lunghe 9 metri e con un diametro di quasi 1 metro, sono perfettamente visibili anche dalla superficie; ricoperte di spugne e organismi marini, non sembrano perfettamente rifinite; anche ripulite, d’altronde, appaiono solo sbozzate, evidentemente inviate come semilavorati da rifinire al porto di destinazione.
L’analisi del materiale rivela dettagli interessanti: tutte le colonne sono in marmo cipollino, una varietà di pregio, apprezzata per le sue fitte nervature verdastre, estratta nelle cave di Karystos in Eubea, la grande isola distesa dinanzi alle coste dell’Attica.
Il relitto di Punta Scifo

Quello di Punta Scifo, sempre nell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, è uno dei più grandi relitti romani di navi lapidarie mai scoperti e documentati. Segnalato nel 1986, scavato nel 1987 e poi nuovamente le 2011-2013, il sito è caratterizzato dalla presenza di 54 grandi blocchi e lastre di marmo bianco, per un peso totale di quasi 360 tonnellate.
Il marmo, analizzato in dettaglio, era per gran parte marmo bianco proconnesio, proveniente da cave sulle rive del Mar di Marmara, nell’attuale Turchia, e marmo pregiato lucido docimeno, dalla Frigia.
La nave, colata a picco nel III secolo d.C., sulla base della datazione della ceramica trovata in prossimità dei marmi, doveva essere lunga 40 metri e larga 14, con uno scafo rinforzato per i trasporti pesanti, come testimoniato da un frammento di legno navale recuperato nel 1987.
Immergersi tra antichi carichi
Il patrimonio archeologico subacqueo è fragile e prezioso, soggetto a danneggiamenti e saccheggi e meritevole della massima tutela. Le navi con carichi di materiali lapidei, per loro stessa natura, soffrono in maniera minore l’azione di saccheggiatori e tombaroli, scoraggiati da recuperi onerosi e complessi, e si prestano agevolmente a una musealizzazione in situ, secondo le indicazioni della Convenzione UNESCO del 2001 per la Protezione del Patrimonio Culturale Sommerso. Più dei relitti con anfore, gli antichi naufragi di navi lapidarie possono essere monitorati con facilità, rendendo così possibile l’organizzazione di immersioni archeologiche di eccezionale fascino: turismo esperienziale di qualità, caratterizzato da impatto minimo e autentica unicità.