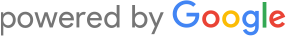Carema

Nonostante le difficoltà dovute al clima non sempre clemente e alla geografia impervia del territorio di Carema, la coltivazione a vite è da secoli parte integrante della cultura contadina di questa località, a metà strada tra le Alpi e la pianura Padana: il vino, nettare di convivialità e gusto, occupa un ruolo centrale nella vita quotidiana della comunità di Carema.
Bastano pochi minuti tra i vigneti, al confine con la Valle d’Aosta, per immergersi in un paesaggio bucolico, solcato da mulattiere e abbellito da topie vitifere, che altro non sono che pergolati, tenuti in piedi da piccole colonne (i pilun), sui quali si annodano i rami delle viti.
I muretti a secco di questi terrazzamenti risalgono dalla conca soleggiata di Carema verso le pendici rocciose dei monti. Qui è il regno del Nebbiolo, il vitigno più diffuso dal quale si ottiene il prestigioso Carema Doc, un vino aromatico, floreale, da gustare tra le cantine e le botteghe del circondario, magari accompagnato da salumi e formaggi locali.
Prima di procedere verso sud, in un contesto di natura curata e suggestiva, meritano una passeggiata anche il borgo antico di Carema e la pieve alto medievale di S. Lorenzo, a Settimo Vittone, per ammirare gli affreschi conservati nel battistero di S. Giovanni Battista.
Ivrea

Costeggiando le pareti di roccia color ruggine che incombono sul paesaggio di Carema, seguendo il corso del fiume Dora Baltea verso sud, si accede in breve alle colline dell’anfiteatro morenico di Ivrea, una zona geologica di origine glaciale costellata di dolci rilievi e laghi, sorvolati da uccelli acquatici e inverditi da una fitta vegetazione.
Si entra così nel Canavese, una regione incastonata tra Torino e la Valle d’Aosta e dominata al centro dalla città di Ivrea, centro abitato di antiche origini che nel Novecento ha fatto molto parlare di sé, da quando la famiglia Olivetti aprì qui un importante complesso produttivo dedicato all’elettronica e alle macchine da scrivere.
Le diverse residenze e palazzine che compongono la città industriale di Ivrea, finanziate dalla Olivetti tra gli anni Trenta e Sessanta, sono oggi collegate dal percorso di visita del MaAM - Museo a cielo aperto dell’architettura moderna di Ivrea. Seguendo un progetto avveniristico per l’epoca, si applicò il concetto di welfare all’architettura e all’urbanistica, per il benessere dei dipendenti aziendali: nel 2018 l’Unesco ha inserito la città industriale di Ivrea nella lista del Patrimonio dell’Umanità.
Bisogna invece dirigersi verso il centro storico della città per scoprire le testimonianze più importanti della lunga storia cittadina — come il castello e la cattedrale di S. Maria Assunta, con il suo chiostro romanico ben conservato —, prima di scendere più in basso per passeggiare lungo le rive della Dora Baltea.
Intorno al lago di Viverone

A circa dieci chilometri da Ivrea, in direzione sud-est, ci si trova davanti al lago di Viverone, il più grande tra quelli dell’anfiteatro morenico di Ivrea. Questo specchio d’acqua prende il nome dal suo centro abitato principale, Viverone, che ricade però nel territorio biellese: le coste del lago sono infatti divise tra le province di Biella, Vercelli e Torino.
Viverone piace a residenti e viaggiatori per le sue spiagge balneabili e facilmente raggiungibili, oltre che per le paludi e i pioppeti che popolano le sue rive, formando un contesto ideale per una passeggiata all’aria aperta.
Attorno al lago, il paesaggio sfoggia le forme sinuose delle colline moreniche e i colori accesi dei campi e delle foreste, creando una cartolina dal calore mediterraneo, nonostante la vicinanza alle Alpi.
Forse è proprio il microclima clemente di quest’area ad aver spinto gli uomini dell’età del Bronzo a costruire alcune palafitte all’altezza del comune di Azeglio, sulla sponda meridionale. I resti di circa 5.000 pali inseriti con perizia nel suolo paludoso del lago di Viverone sono oggi visibili e visitabili, e fanno parte del Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2011 all’interno del sistema dei “Siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino”.
Di ben più recente costruzione, ma altrettanto interessante e coinvolgente, è la splendida struttura del castello e parco di Masino, che domina dall’alto i rilievi dell’anfiteatro morenico di Ivrea. La famiglia aristocratica dei conti Valperga di Masino commissionò la costruzione di questa grande dimora di rappresentanza tra il Cinquecento e il Settecento. I grandi saloni del castello sono ricchi di arredamenti di pregio, affreschi e decorazioni, mentre attorno al castello si apre un giardino rigoglioso, abbellito da tempietti, viali alberati e da un labirinto vegetale composto da migliaia di piante di carpino.
Agliè

Bisogna spostarsi verso il borgo di Agliè, non lontano dal passaggio del torrente Orco, per visitare un altro castello che, come quello di Masino, lega la sua storia alle secolari vicende dell’aristocrazia piemontese. Questa volta è stata la casata dei Savoia a finanziare la creazione di un imponente complesso che servisse da residenza reale, affiancandosi alla già corposa lista di regge sabaude costruite dai re piemontesi.
Protette dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità con un sito seriale, le residenze Savoia contano ventidue edifici che formano una “corona di delizie”, dentro e intorno alla città di Torino.
Circa trecento stanze di diverse dimensioni e funzioni si distribuiscono attraverso gli immensi spazi interni del castello ducale di Agliè.
Tra queste spicca per bellezza e importanza il salone da ballo secentesco, stuccato e riccamente affrescato, oltre alle monumentali cucine della reggia, da visitare prima di scendere verso il parco per una passeggiata tra fontane, statue, siepi e prati fioriti.
Non meno affascinante del castello è il piccolo insediamento che circonda la reggia, il borgo a cui il Touring Club Italiano ha assegnato la Bandiera Arancione, per la sua offerta e accoglienza turistica di grande qualità. Tra i viottoli porticati e le palazzine pittoresche, l’antica Alladium (così si chiamava Agliè in epoca romana e medievale) conserva due belle chiese barocche, dedicate a S. Marta e S. Massimo.
Sarà difficile, tra le botteghe del borgo, non incappare in una confezione di torcetti di Agliè, deliziosi biscotti tipici, o in una bottiglia di gustoso vino delle Doc Canavese, Rosso, Barbera o Nebbiolo.
Caluso

Si è ormai alle porte di Torino quando, tra i campi e i piccoli insediamenti industriali tipici del Canavese, si svelano alcuni dei vigneti più prestigiosi dell’intero Piemonte, quelli del vitigno Erbaluce, caratteristico di Caluso, conosciuto già in epoca romana, quando era noto come alba lux (luce albeggiante) per via del suo colore bianco e brillante come l’alba.
I rilievi di origine glaciale dell’anfiteatro morenico di Ivrea, ricchi di argilla e ciottoli, sono adatti alla coltivazione di quest’uva bianca, da cui si ottiene l’Erbaluce di Caluso Docg. Si tratta di un vino di colore giallo paglierino, leggermente acidulo, agrumato e fruttato, ottimo da gustare con i pesci dei tanti laghi e fiumi che bagnano la provincia di Torino, o magari con il salame di patata, che mischia suino e tubero regalando un sapore contrastante e particolare.
In alternativa al bianco Erbaluce, i buongustai sapranno apprezzare anche il Caluso passito, ottenuto dallo stesso vitigno ma decisamente più dolce e corposo, anche per gradazione alcolica.
Il microclima di Caluso e dei suoi dintorni, ideale per i vigneti alpini, è favorito anche dalla presenza di un piccolo specchio d’acqua, quello del lago di Candia, circondato da un parco naturale e popolato da uccelli acquatici come tarabusi, moriglioni e aironi. Il lago è un’ottima meta da esplorare in barca, in canoa o in bicicletta.
Pinerolo

Con il palato ancora pervaso dei sapori dei vini di Caluso, si percorre tutta l’area metropolitana di Torino per raggiungere, dopo circa 80 chilometri, un’altra zona ricca di storia, cultura e vino, che si sviluppa intorno a Pinerolo e lungo le vallate alpine che da qui procedono verso il confine francese: la val Pellice, la val Germanasca e la val Chisone.
Tra i vigneti del Pinerolese Doc, e specialmente intorno ai borghi di Pomaretto, a circa 600 metri di altitudine, uve a bacca nera di diversa tipologia regalano una grande varietà di rossi, che spazia dal Barbera alla Bonarda, dal Dolcetto alla Freisa, giusto per citare le denominazioni più conosciute.
La lunga tradizione enogastronomica di questa parte di Piemonte abbina il vino pinerolese a una serie di delizie locali, capaci di esaltarne i sapori e il retrogusto, come i funghi, meglio se porcini, i formaggi (robiole in foglie di castagno e tomini) e le lumache.
Prima di zigzagare tra i vigneti alpini delle valli pinerolesi, capaci anche qui di arrampicarsi sorprendentemente lungo i crinali della montagna, la città di Pinerolo merita certamente una visita approfondita.
Le sue vicende storiche sono legate alla famiglia degli Acaja, imparentata con la dinastia Savoia, che scelse Pinerolo come punto di riferimento urbano dei suoi vasti possedimenti nella regione circostante, in particolare grazie al clima mite che la rese nota come la Nizza del Piemonte, incastonata com’è in una conca spesso battuta dal sole.
Tra le tortuose vie porticate del centro storico, sulla dorsale del colle che, da nord, si affaccia sulla città moderna, si nascondono alcuni dei principali monumenti pinerolesi, come la chiesa di S. Maurizio, dominata da un alto e affusolato campanile di mattoni rossi, e il Duomo intitolato a S. Donato.
Fenestrelle

Vera perla di autentico Piemonte alpino, Fenestrelle si posiziona al centro della val Chisone, che da Pinerolo procede verso ovest, lungo un tracciato che per millenni è stato al centro delle vie commerciali, e delle contese politiche, tra Italia e Francia.
Non a caso i Savoia, per difendersi dall’esercito francese, scelsero questa località per installare tra il Settecento e l’Ottocento il forte di Fenestrelle una grandiosa serie di contrafforti e muraglie difensive difficilmente valicabili, che si sviluppa per centinaia di metri lungo le pendici della montagna, sulla riva sinistra del torrente Chisone.
Il bizzarro nome del villaggio, dolcemente adagiato ai piedi del forte di Fenestrelle, deriva dal termine latino “finis terrae cotii”, infatti, prima dell’invasione romana, qui terminavano le terre governate dalla tribù celto-ligure dei Cozii, che ha dato il nome anche a questo tratto di arco alpino piemontese, quello delle Alpi Cozie.
Così come Agliè, anche il borgo di Fenestrelle ha ricevuto la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, che sta a indicare l’eccellenza del suo sistema di accoglienza turistica. Non resta allora che visitare le botteghe e i vicoli del borgo antico, tra terrazzi e finestre da cui sporgono vasi fioriti e colorati, alla ricerca di un assaggio di Plaisentif, un formaggio di vacca tipico di Fenestrelle.
Per vivere attimi di natura incontaminata si può infine esplorare il Parco naturale dell’Orsiera-Rocciavrè, che si sviluppa intorno a Fenestrelle: caprioli e cervi, camosci e marmotte, pernici, civette e tante altre specie faunistiche alpine vivono tra i rilievi boscosi di questa splendida riserva naturale.
Exilles

Al termine della val Chisone si supera la scintillante bellezza di Sestriere, mecca degli sport invernali e sede di diverse gare durante le Olimpiadi di Torino 2006, prima di sboccare in val di Susa, costeggiando il confine francese fino a Exilles, termine di questo itinerario tra fortezze e vigneti eroici.
Piacevole da visitare a piedi, tra i viottoli che circondano la chiesa di S. Pietro Apostolo, il borgo di Exilles, compatto e dall’aspetto tipicamente alpino, giace ai piedi di un colle su cui spicca l’imponente mole di un forte difensivo, utilizzato per secoli a volte dai francesi e altre volte dai Savoia, per proteggersi dalle reciproche minacce militari.
Il forte di Exilles ha origine medievale ma ha subito distruzioni e rifacimenti per lunghi secoli, colpito da esplosioni e battaglie durante i tanti scontri sulla frontiera alpina, fino alla completa e definitiva ricostruzione in epoca ottocentesca, decisa dai re sabaudi, che diede al fortilizio l’aspetto che vediamo ancora oggi.
Spartiacque storico per le vicende della rocca di Exilles sono gli anni della seconda guerra mondiale: a partire dal 1945, infatti, il forte ha perso la sua funzione difensiva, ed è diventato da alcuni anni sede di esposizioni ed eventi culturali.
Non si poteva chiudere questo percorso turistico lungo la Strada dei vigneti alpini senza accennare alla tradizione vitivinicola che, anche in val di Susa, regala ottimi vini di montagna, principalmente rossi. La Doc Valsusa si distribuisce su ripide coltivazioni a terrazzamenti che si spingono fino ad altitudini eccezionali, superando a volte i mille metri di quota.