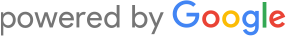La basilica di S. Antonio e Prato della Valle

L’itinerario parte dalla basilica di S. Antonio, l’oratorio di S. Giorgio, Prato della Valle, S. Giustina, e l’Orto botanico, nell’area antica e storicamente centrale di Padova che vanno a comporre la Cittadella Antoniana.
La basilica di S. Antonio è il cuore di un quartiere in cui tutto, dai negozi di souvenir alla toponomastica, richiama il patrono della città. È la meta preferita di oltre 6,5 milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Perdersi è impossibile perché la basilica domina la prospettiva delle vie circostanti con le sue otto cupole che le conferiscono un aspetto bizantineggiante.
Accanto, sulla piazza del Santo, si affaccia anche il bellissimo oratorio di S. Giorgio, affrescato da Altichiero da Zevio nel 1384 con scene della vita di S. Giorgio, un’opera che risente fortemente dell’influenza giottesca.
Nella Cittadella Antoniana c’è spazio anche per qualche sosta “profana”. Intorno alla bellissima piazza di Prato della Valle, collegata alla piazza del Santo da via Beato Luca Belludi, ci sono locali per tutti i gusti, mentre per una rilassante camminata nel verde si va al vicino Orto botanico, fondato nel 1545 e Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
L’Università patavina e il centro medievale

In pochi passi il centro medievale di Padova racchiude anime diverse, eredi di un passato lungo e prosperoso. Si può partire da via VIII Febbraio dove, una di fronte all’altra, si trovano due importanti istituzioni cittadine, l’Università e il Municipio. La prima occupa dal 1492 gli spazi di palazzo del Bo, l’altra quelli palazzo Moroni, sede del governo cittadino dal ‘200. Passando sotto l’arco di palazzo Moroni si accede alle piazze gemelle delle Erbe e della Frutta, tra le quali si innalza il palazzo della Ragione, sede di mercato da secoli. A pochi passi, lungo via S. Clemente, si apre piazza dei Signori, che come il nome lascia intendere ha un’origine aristocratica: qui abitavano infatti i Carraresi, signori di Padova dal 1318 al 1405 e e sembra ancora di vedere i nobili passeggiare e sfidarsi a "singolar tenzone". I due lati corti della piazza sono chiusi dalla chiesa di S. Clemente, di antichissima origine e parzialmente ricostruita a fine ’500, e dalla parte opposta dal palazzo del Capitanio con al centro l’elegante Torre dell'Orologio. Superato l’arco che si apre alla base della torre si accede alla piazza del Capitaniato, e sembra di stare in un altro mondo. Intima e alberata, presidiata dal palazzo Liviano, sede della facoltà di Lettere e Filosofia, è territorio esclusivo degli studenti universitari e di qualche bar a loro servizio. Infine, avviandosi lungo via dell’Accademia, dopo pochi passi si scorgono l’abside e il campanile del Duomo, cinquecentesco al cui progetto lavorò anche Michelangelo, affiancato dal battistero di S. Giovanni Battista affrescato da Giusto de’ Menabuoi.
Il complesso degli Eremitani

Era un convento vasto e potente quello degli Eremitani di S. Agostino, situato a nord del centro sulle rive del fiume Bacchiglione e, come oggi, immerso nel verde: se ne ha un buon colpo d’occhio dal bel ponte Giuseppe Garibaldi che conduce alla stazione ferroviaria.
Nel ‘300 la chiesa del convento era uno dei cantieri cui si deve il patrimonio di affreschi patavini tutelato dall’Unesco. Vi lavorarono, più o meno negli stessi anni, Giusto de’ Menabuoi, Guariento di Arpo e Altichiero da Zevio. Il capolavoro della chiesa, però, risale a un secolo più tardi ed è la cappella Ovetari affrescata da Andrea Mantegna. Purtroppo, nel 1944, la chiesa venne colpita da uno sciagurato bombardamento aereo e, del ciclo di affreschi del Mantegna, ci restano solo poche scene e alcune fotografie in bianco e nero di inizio Novecento.
Oggi gli ambienti del convento custodiscono i musei civici d’archeologia, d’arte medievale e moderna e di arti applicate, ma l’obiettivo dei quasi 190.000 visitatori che ogni anno raggiungono il complesso degli Eremitani è l’edificio accanto: la Cappella degli Scrovegni.
Cappella degli Scrovegni

La Cappella degli Scrovegni, in origine, non apparteneva al complesso degli Eremitani: gli annali raccontano, anzi, di una controversia tra gli Eremitani e la famiglia degli Scrovegni che fu infine costretta a ridimensionare il progetto iniziale di una chiesa ben più imponente.
Enrico Scrovegni fece erigere questa cappella dedicata a S. Maria della Carità, nel 1303-1305, a fianco dell’imponente palazzo della sua potente famiglia chiamando ad affrescarla Giotto. Ne nacque un ciclo di storie della Vergine e di Cristo articolato in 38 episodi, che costituisce uno dei massimi monumenti della pittura italiana. Nello zoccolo delle pareti si trovano le figurazioni monocrome delle sette Virtù e dei sette Vizi capitali, mentre nella controfacciata spicca il Giudizio universale. Dietro l’altare si trova il sepolcro di Enrico Scrovegni. Nel 2002, complessi lavori di restauro hanno eliminato gli elementi estranei alla pittura originale e fatto emergere nuovi aspetti del metodo di lavoro di Giotto, come l’utilizzo in alcune parti della tecnica a olio o di quella del marmorino per la decorazione.
Dalla Cappella intraprendete, infine, una passeggiata costeggiando le mura rinascimentali della città per andare alla scoperta di altri tesori legati alla storia di Padova.
Porte Contarine e il giro delle mura

Padova conserva ancora la cinta di mura veneziane di epoca rinascimentale, ben 11 chilometri scanditi da 19 bastioni e 6 porte superstiti, in buona parte bagnata dai fiumi e dai canali della città e immersa nel verde. Interamente percorribile, la cinta muraria è luogo di lunghe passeggiate, pedalate panoramiche, gare podistiche, crociere sulle vie d’acqua e visite guidate. La piacevole passeggiata che dal complesso degli Eremitani percorre la cinta verso sud in senso antiorario permette di scoprire alcuni angoli suggestivi fuori dagli itinerari più battuti. Partendo dalle Porte Contarine, che costituiscono il terminale delle minicrociere turistiche nei canali e nei fiumi padovani, si arriva alla porta Molino, tra le architetture medievali meglio conservate della città, si prosegue lungo il tratto alberato della Riviera S. Benedetto, sulla sponda sinistra del fiume Bacchiglione, che bordeggia diversi edifici storici. Infine, all’altezza del ponte Paleocapa, il colpo d’occhio sulla Torre della Specola, antico osservatorio astronomico dell’Università e, nelle vicinanze, una piccola oasi naturalistica popolata di uccelli acquatici.