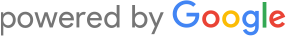Urbino

Nella seconda metà del ’400 Urbino è la città di Federico da Montefeltro e del figlio Guidobaldo, il suo successore. Ricchezza e potere della signoria crescono anno dopo anno e la città cambia rapidamente volto: il duca vuole che sia all’altezza di una vera capitale, a partire dal Palazzo Ducale, che si va trasformando in una splendida cittadella. A corte, tra uomini d’arme e diplomatici di mezza Europa circolano poeti, scienziati, musicisti, architetti e artisti di primissimo piano, non solo italiani. Uno di essi, pittore e anche poeta, è Giovanni Santi, il padre di Raffaello. La sua casa, che è abitazione e anche bottega, dista appena 350 metri dal palazzo: riconoscerla è facilissimo, oggi è un museo, la Casa natale di Raffaello. Raffaello vi nasce nel 1483, quando il duca Federico è scomparso da appena un anno. Si forma dunque nel più stimolante degli ambienti, tra la corte, la bottega paterna e una serie di palazzi e chiese dove può ammirare opere dei massimi artisti del tardo Medioevo e del primo Rinascimento. Chiese e palazzi sono ancora lì, a donare il loro contributo di bellezza a una città che nel frattempo è diventata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. E molti di quei capolavori d’arte, firmati per esempio da Piero della Francesca e Pedro Berruguete, Melozzo da Forlì, Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini, sono rimasti anch’essi a Urbino, nella Galleria nazionale delle Marche, che è stata allestita proprio all’interno del Palazzo Ducale.
Città di Castello

Nel 1500 Raffaello è poco più di un ragazzo, ma a Urbino già lo chiamano “maestro” e il suo nome inizia a circolare anche altrove, soprattutto in Umbria. Città di Castello, l’antica Tifernum Tiberinum, ha il merito di dargli subito fiducia, tanto da essere ricordata come il vero “trampolino di lancio” della carriera di Raffaello. La prima commissione tifernate certa risale proprio al 1500, si tratta di una pala d’altare, la pala Baronci, chiesta a Raffaello per decorare la chiesa di S. Agostino. Di quell’opera, danneggiata dal terremoto del 1789, sopravvivono però solo alcuni frammenti, sparsi tra vari musei italiani e stranieri. Migliore fortuna avranno due autentici capolavori realizzati sempre a Città di Castello per le chiese di due ordini mendicanti tradizionalmente in competizione, i frati francescani e domenicani: rispettivamente lo Sposalizio della Vergine oggi a Milano, tra gli highlights nella Pinacoteca di Brera, e la Crocifissione Mond (o crocefissione Gavari), che è invece tra le opere più preziose della National Gallery di Londra. Di entrambe, nelle chiese di S. Francesco e di S. Domenico si possono ammirare le copie. A Città di Castello rimane soltanto un’opera originale di Raffaello, dalla datazione incerta. È lo stendardo della SS. Trinità, un gonfalone processionale che alcuni ritengono addirittura precedente alla pala Baronci, collocandolo nel 1499, e altri reputano del 1504, anno in cui Raffaello è già diventato un cittadino perugino. È esposto nella bella Pinacoteca comunale allestita in palazzo Vitelli alla Cannoniera.
Perugia

Il grande affresco della SS. Trinità realizzato per metà da Raffaello e per metà da Perugino, nella cappella di S. Severo, è la principale testimonianza del soggiorno di Raffaello a Perugia. Il pittore di Urbino arriva nel capoluogo umbro quando ancora non ha compiuto 20 anni, intorno al 1502, ma nel giro di poco si sposta definitivamente a Firenze. È un periodo chiave per la sua crescita artistica e per la sua affermazione. A Perugia infatti si confronta direttamente con l’opera di Pietro Perugino e Pinturicchio, maestri che in città e nei dintorni hanno disseminato capolavori. Alle famiglie nobili della città, che con l’arte hanno una discreta confidenza, basta un attimo per rendersi conto che il nuovo arrivato ha un talento fuori scala: e così al giovane Raffaello cominciano ad arrivare commissioni per opere di alto profilo.
Purtroppo, a eccezione dell’affresco di S. Severo, di quei dipinti a Perugia rimangono solo copie, mentre gli originali rifulgono in alcuni dei maggiori musei del mondo. Nella Galleria nazionale dell’Umbria di palazzo dei Priori sono esposte, tra l’altro, la copia della predella della pala Colonna con le Storie della Passione di Cristo (1503-05) oggi al Metropolitan di New York; e soprattutto due copie della celeberrima pala Baglioni (o Deposizione Borghese) commissionata a Raffaello nel 1504, un tempo collocata nella chiesa di S. Francesco al Prato ma oggi esposta nella Galleria Borghese a Roma. Nella chiesa di S. Fiorenzo dei Serviti c’è invece una copia della pala Ansidei, una Sacra conversazione che si può ammirare alla National Gallery di Londra.
Bologna

Nel corso della sua vita Raffaello non si stabilisce mai a Bologna: eppure lascia una traccia importante nella storia culturale e un autentico tesoro nel patrimonio museale della città. La relazione tra Raffaello e Bologna si sviluppa infatti negli anni in cui il pittore è a Roma, al servizio di papa Giulio II e del suo successore Leone X. Nel 1506 il papato ha riportato la città sotto la propria autorità e il gruppo di artisti attivi alla corte pontificia è diventato il punto di riferimento anche per la committenza bolognese: dal 1509, di quel gruppo fa parte anche Raffaello. L’incarico più importante gli arriva da una devota nobildonna, Elena Duglioli dall’Olio, che gli commissiona una pala per l’altare della cappella Duglioli o di S. Cecilia, nel transetto sinistro della chiesa di S. Giovanni in Monte: è la celebre Estasi di santa Cecilia. Secondo la tradizione, Raffaello inizia a dipingerla nel 1513 e la conclude nell’agosto 1515, anno in cui probabilmente è a Bologna di persona, al seguito di Leone X per l’incontro tra il Papa e il re di Francia Francesco I.
La Francia torna nella storia dell’Estasi di santa Cecilia molti secoli più tardi, al tempo delle conquiste di Napoleone. Come altri capolavori dell’Urbinate, infatti, per volontà dell’imperatore l’Estasi di santa Cecilia viene strappata all’Italia e portata a Parigi per essere esposta al Louvre. In seguito l’opera rientra in patria grazie al lavoro di Antonio Canova: oggi è esposta nelle sale della ricca Pinacoteca nazionale di Bologna. Nella chiesa di S. Giovanni in Monte, invece, se ne può vedere una copia.