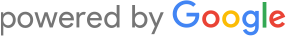La diga del Vajont: un monumento alla memoria e alla natura
3 minuti
Immersa nello scenario spettacolare delle Dolomiti friulane, la diga del Vajont testimonia l’ingegno e allo stesso tempo l’arroganza dell’uomo nei confronti della natura.
Costruita per fornire energia elettrica alle valli sfruttando le acque del torrente Vajont, il 9 ottobre del 1963 la diga provocò una frana che dal monte Toc, situato a ridosso del torrente, precipitò nel lago artificiale creato dalla diga. L’onda di risalita devastò completamente Longarone e in parte i paesi di Erto e Casso, provocando quasi 2.000 vittime.
La storia

Il torrente Vajont scorre nella valle di Erto e Casso, oggi in provincia di Pordenone, e confluisce nel Piave davanti al paese di Longarone, che è in provincia di Belluno.
La vicenda dello sfruttamento economico delle sue acque ha origini lontane: la prima proposta, a cui seguono diverse altre, risale addirittura all’inizio del 1900. Il progetto vero e proprio per la costruzione di quella che doveva diventare la diga più grande del mondo risale però a circa cinquant’anni più tardi: i lavori iniziano infatti nel 1957, tra l’altro senza l’autorizzazione ministeriale, che arriverà solo nel 1959 quando i lavori sono ormai giunti a buon punto.
Lo sbarramento del torrente Vajont doveva consentire la creazione di un grande bacino per la produzione di energia idroelettrica. L’azienda costruttrice è la Sade (Società Adriatica di Elettricità).
La diga, 261 m di altezza e 190 m di lunghezza, diventa un colosso artificiale nella valle: un’installazione di potere, un simbolo della fiducia dell’uomo nella sua capacità di dominare la natura.
Prove e avvertimenti

Nel settembre 1959, a diga ultimata, iniziano le prove di invaso. Incidenti negli impianti vicini inducono la Sade a effettuare una serie di controlli, che individuano movimenti instabili del fianco del monte Toc, sotto la cui superficie si notano masse in lento cedimento: in pratica, è una frana di antica origine, con un fronte di 2,5 km. Nel novembre 1960, un blocco di 700 mila metri cubi di roccia precipita all’interno dell’invaso generando un’onda di circa 10 metri di altezza. Fortunatamente non ci sono vittime. Le prove di svaso e invaso continuano provocando altri movimenti della frana. La Sade e la commissione ministeriale di controllo ignorano o minimizzano questi segnali. Anzi, l’obiettivo è quello di collaudare la diga portandola al massimo delle sue possibilità: raggiunti i 700 m, si decide di proseguire con un ulteriore innalzamento del livello dell’invaso, portandolo a 715 m slm.
Il disastro

Il 9 ottobre 1963, alle 22:39, una massa enorme di roccia, stimata in circa 260 milioni di metri cubi, si stacca dal monte Toc e precipita nel lago artificiale creato dallo sbarramento della diga del Vajont. Il fronte d’acqua generato sale per decine di metri sui fianchi del versante opposto, supera la diga stessa e si scatena sulla vallata sottostante, travolgendo Longarone e i paesi limitrofi.
In pochi minuti, muoiono 1.917 persone, 400 delle quali mai più ritrovate. Paesi interi scompaiono sotto un’onda smisurata di acqua e detriti che spazza via case, strade e vite umane.
Il ruolo dello Stato
Nella storia del disastro del Vajont, la creazione dell’Enel nel 1962 è un fatto determinante: la Sade è infatti interessata a vendere i propri impianti alla nuova azienda elettrica di Stato e per questo motivo, nonostante prove e accertamenti rivelino la possibilità di situazioni catastrofiche, queste informazioni non vengono comunicate alla commissione ministeriale. L’Enel acquista dunque l’impianto del Vajont nel marzo 1963 e procede seguendo quanto già iniziato dalla Sade, trascurando le preoccupazioni espresse dalle amministrazioni comunali locali, dal Consiglio provinciale di Belluno, dall’assemblea del Bacino Imbrifero del Piave, da alcuni giornalisti e dai comitati a cui partecipano centinaia di cittadini.
Il dopo-Vajont fu una lunga agonia civile: processi, contenziosi, riconoscimenti e rinunce. Lo Stato si trovò a essere contemporaneamente vittima e responsabile, giudice e imputato.
Il Vajont oggi

Il disastro del Vajont non ha provocato particolari danni alla diga, che infatti oggi è ancora lì, monumento alla memoria. Sul territorio, invece, le tracce della tragedia sono indelebili: l’immensa frana, innanzitutto, e i resti degli edifici che gli abitanti della valle ripuliscono regolarmente dalle erbacce.
Per chi vuole conoscere la storia di questa vicenda, il Parco delle Dolomiti friulane ha allestito una mostra all’interno del Centro visite di Erto e Casso e organizza visite guidate di diversa durata al coronamento della diga e agli altri luoghi significativi: l’ex cantiere, il percorso ai piedi del monte Toc, il bosco cresciuto sopra la frana. Meritano una visita anche i paesi di Erto e Casso con le loro tipiche architetture.