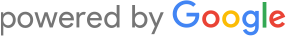Topografie della memoria
6 minuti
Topografie della memoria è un percorso storico, ma anche emotivo del territorio tra Gorizia e Nova Gorica. Si compone di 10 tappe (6 a Gorizia e 4 a Nova Gorica), segnalate con un totem sul quale è apposto un codice QR che consente l’accesso a una serie di contenuti multimediali e audiovisivi. Ci sono interviste, filmati e fotografie raccolti nell’ambito di un progetto che ha coinvolto i cittadini di Gorizia e Nova Gorica che hanno vissuto nell’area di confine nella prima metà del Novecento.
Queste storie personali dialogano con la storia ufficiale e valorizzano la specificità storica dei luoghi della città spesso dimenticati o nascosti.
Parco della rimembranza

Il Parco della Rimembranza fu inaugurato negli anni Venti del Novecento in un’area che fino ad allora aveva ospitato il cimitero cittadino. Nel 1929 vi fu collocato un tempietto neoclassico, opera di Enrico Del Debbio, dedicato ai volontari goriziani che nel corso della Prima Guerra mondiale (quando Gorizia apparteneva all’Impero asburgico) avevano scelto di arruolarsi nell’esercito italiano, disertando quello austriaco. Negli anni successivi il parco si arricchì di busti, targhe e monumenti in ricordo di personaggi ed eventi del Risorgimento e della Grande Guerra, diventando, in questo modo, un luogo simbolico dell’italianità di Gorizia.
Dopo la resa dell’esercito italiano agli alleati nel 1943, il parco divenne teatro di scontri tra i domobranci sloveni e i fascisti italiani: entrambe le parti erano alleate con i nazisti, ma allo stesso tempo erano in conflitto tra loro perché ciascuna rivendicava il possesso del territorio di Gorizia. Nel 1944, il tempietto, simbolo d’italianità, venne fatto esplodere dai domobranci con la complicità dei tedeschi. Le sue macerie diventarono lo scenario per manifestazioni e commemorazioni della componente italiana della città. Nel 1946, durante una di queste manifestazioni, ci fu un attentato attribuito ai gruppi filo-jugoslavi che in quella fase, in cui Gorizia era ancora gestita dal Governo militare alleato, stavano lottando per l’annessione della città alla Jugoslavia. In seguito all’attentato ci furono violente reazioni della popolazione italiana contro gli sloveni.
Trgovski Dom

L’edificio del Trgovski Dom (Casa del commercio) fu commissionato dal Consorzio commerciale e industriale sloveno di Gorizia all’architetto Max Fabiani (1865-1962) nei primi anni del Novecento. In quel momento, la comunità slovena di Gorizia era molto numerosa e influente nella vita cittadina. Fabiani progetta un edificio innovativo nello stile e nell’organizzazione interna degli spazi, adatto ad ospitare istituzioni economiche e culturali, uffici, negozi e anche un piccolo teatro e una biblioteca. Il Trgovski Dom diventa un centro di riferimento per la popolazione slovena della città e proprio per questo nel 1927 viene incendiato dai fascisti e poi trasformato in “Casa del fascio”. Tra il 1945 e il 1947, durante il periodo di amministrazione alleata, diventa invece “Casa del popolo”. È nuovamente espropriato dallo Stato italiano nel 1947 e destinato prima a sede di uffici pubblici e poi assegnato alla Lega nazionale. In questi ultimi anni è stato assegnato alla Biblioteca Statale Isontina e alle associazioni slovene, trovando così finalmente una collocazione che rispetta tutta la comunità cittadina.
Da via Roma a piazza della Vittoria

L’attuale via Roma, sguarnita di edifici fino alla Prima Guerra mondiale, assume un ruolo significativo durante il periodo fascista, diventando il perno del piano di edilizia pubblica progettato dal regime. Arteria privilegiata per raggiungere la piazza centrale, è stata lo scenario di diverse sfilate: nel 1938 ospita la sfilata cerimoniale in occasione della visita ufficiale del duce, nel maggio 1945 è attraversata dai partigiani jugoslavi, nel 1946 dai cortei filo-jugoslavi, nel 1947 dai partecipanti alle cerimonie in onore dei militari anglo-americani e da coloro che accolsero l’ingresso delle truppe italiane nel 1947.
Da via Roma si raggiunge piazza della Vittoria, la piazza principale della città, teatro di tutte le più importanti manifestazioni cittadine nel corso del suo travagliato Novecento. Il 20 settembre del 1938 qui si tiene il comizio del duce, che è di ritorno da Trieste dove due giorni prima ha annunciato l’introduzione delle leggi razziali antiebraiche. Nel 1940, gli altoparlanti collocati nella piazza annunciano ai goriziani l’entrata in guerra e durante il conflitto è l’adiacente galleria Bombi a dar rifugio a molte persone durante i bombardamenti.
Dopo la resa italiana, tutta l’area del nord est dell’Italia passa sotto il controllo amministrativo e militare della Germania nazista. Le truppe tedesche occupano tutti i principali palazzi del potere e utilizzano la piazza per le loro sfilate.
Nel 1945, durante i quaranta giorni di amministrazione jugoslava nella piazza sventolano le bandiere dei partigiani di Tito e poi, nei due anni di Governo militare alleato, quelle inglesi e statunitensi. In questo periodo si susseguono anche le manifestazioni degli abitanti di Gorizia, che a seconda della loro appartenenza, rivendicano l’annessione di Gorizia alla Jugoslavia o all’Italia.
Nel 1946 arriva a Gorizia la Commissione alleata per la definizione dei confini: il 27 marzo trentamila goriziani invadono piazza Vittoria per sostenere l’annessione all’Italia. Probabilmente, fu proprio questo episodio a indurre la commissione alla scelta di lasciare Gorizia all’Italia.
Valico di frontiera di Casa Rossa / Rožna Dolina

Il valico di Casa Rossa, che diventò in seguito il principale valico di frontiera tra Italia e Jugoslavia, fino al 1955 era inaccessibile alla maggior parte delle persone. Il passaggio era infatti consentito solo ai contadini che avevano delle proprietà “dall’altra parte” ed erano quindi provvisti di un lasciapassare agricolo.
La divisione della città disposta dal nuovo confine nel 1947 creò molte difficoltà ai goriziani che avevano scelto di vivere in Jugoslavia, che si ritrovano senza un centro cittadino e quindi anche senza servizi e senza negozi. L’esasperazione dei cittadini di Nova Gorica si manifestò all’improvviso una domenica di agosto del 1950, quando una falsa notizia che annunciava l’apertura straordinaria del confine indusse le persone ad oltrepassare in massa il valico di Casa Rossa senza mostrare il lasciapassare. L’episodio non ebbe gravi conseguenze e consentì alle persone di rifornirsi di alcuni semplici generi di uso quotidiano ormai introvabili nella zona jugoslava, per esempio le scope di saggina. Proprio questo oggetto darà il nome all’intera giornata, che ancora oggi è ricordata come “domenica delle scope”.
Valico del Rafut e Kostanjeviška Cesta

Quello del Rafut era un valico di seconda categoria, riservato agli abitanti della fascia confinaria muniti di lasciapassare. È collocato in una piccola strada che nel 1947 viene attraversata dal nuovo confine. Il tracciato confinario fu spesso definito in modo intransigente: in questo tratto, per esempio, si ricorda ancora il caso di una famiglia che si trovò con l’abitazione in Italia e la stalla in Jugoslavia. Solo dopo i trattati di Osimo del 1975 si riuscirà a modificare leggermente il tracciato ricongiungendo alcune proprietà che erano state divise.
Oltre il confine, il percorso prosegue sulla Kostanjeviška Cesta (via Castagnevizza), dominata dall’omonima collina in cui sorge un monastero, oggi ricordato soprattutto perché vi sono sepolti gli ultimi re Borboni di Francia.
Piazza della Transalpina / Trg Evrope

Il nome italiano della piazza è quello della stazione della linea ferroviaria che fu inaugurata nel 1906 dall’Arciduca Francesco Ferdinando per collegare Trieste con Jesenice e l'Europa centrale. Nel 1947, la piazza fu divisa dal nuovo confine e per molti anni fu controllata rigidamente dalle guardie confinarie. La facciata della stazione rivolta all’Italia aveva, accanto alla stella rossa simbolo del socialismo, anche la scritta “Mi gradimo socijalizam” (Noi costruiamo il socialismo).
Con l’adesione della Slovenia all’Unione Europea il Primo maggio 2004, la rete divisoria che per più di 50 anni aveva diviso Gorizia da Nova Gorica venne abbattuta e la piazza riassunse il suo carattere unitario, a cavallo di due Stati. Simbolicamente, però, la piazza mantiene anche il nome sloveno Trg Evrope.
L’itinerario prosegue a Nova Gorica, la nuova città di moderna concezione che doveva diventare una “vetrina socialista” per l’Occidente. Il primo progetto risale al 1947 e fu ispirato alle realizzazioni di Le Corbusier. Il progettista Edvard Ravnikar disegnò una città giardino, con molte aree verdi e quartieri nettamente separati e distinti in base alla loro funzione: abitativa, commerciale, amministrativa. Questo primo progetto venne realizzato soltanto in parte lungo le due vie principali. In seguito, la riduzione dei mezzi finanziari impose nuove soluzioni.