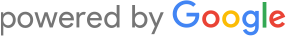Il percorso inizia a Chivasso, che del Canavese può essere considerata la porta meridionale, dove un lungo ponte valica il Po e un viale contornato di pioppi introduce al centro storico, segnato dalla torre ottagonale dell’antico Castello e dall’elegante facciata in cotto tardo-gotica del Duomo. Del suo significativo sviluppo industriale nulla lascia indovinare la parte antica della città, che mantiene il suo sapore ottocentesco. Chivasso è anche famosa per il suo “Carnevalone” e, sfilando tra i suoi portici e i suoi negozi, si può incappare in uno dei mercati ortofrutticoli più ricchi del Canavese.
Come possibile deviazione da Chivasso è possibile seguire la strada che costeggia il Canale Cavour (1883-86), terzo in Italia per lunghezza (80 km) sino ad arrivare a Verolengo, borgo di grande fascino e luogo di insediamenti urbani sin dai tempi dell’antica Roma
Proseguendo in direzione di Caluso ed oltrepassandola, merita una visita lo scenario incontaminato di Candia Canavese con il suo lago, seconda tappa della giornata.

Sul picco della collina che domina il paese si innalza la romanica Chiesa di Santo Stefano del Monte, edificata nell’XI secolo e già sede di un priorato benedettino. La parte più suggestiva della chiesa, divisa in tre navate, è la cripta, sostenuta da esili colonnine e capitelli decorati. Fino al 1970 qui era custodita una veneratissima statua in marmo dipinto della Madonna con Bambino, oggi conservata nella parrocchiale di Candia. Dal prato che circonda la chiesa si gode di un colpo d’occhio favoloso sul lago.
A pochi minuti dal centro c’è il lago di Candia, una delle zone umide più interessanti del Piemonte, riserva naturale e meta di appassionati di birdwatching. Lungo 2,2 km e largo 900 m, il lago (m 226) è tutelato da un Parco naturale provinciale. È ricco di avifauna stanziale e di passo dando riparo a numerose varietà di uccelli nidificanti e svernanti nelle aree paludose sulla costa a nord. Sul lago è possibile concedersi una sosta rilassante, puntellata da una splendida atmosfera, all’interno di una riserva naturale incontaminata. Itinerari sterrati sono segnalati per le mountain bike, che si affittano lungo il litorale. Le acque tranquille del lago sono ottime per kayak, canoa, canoa canadese e dragonboat.
La strada prosegue permettendo di ammirare l’ampio specchio d’acqua del lago, solcato dai canottieri, con le montagne dell’acrocoro alpino che vi si specchiano. Poi il lago lascia spazio alla pianura canavesana, costellata di campi di granturco, con bella vista sull’Anfiteatro Morenico di Ivrea. Lo scenario a questo punto muta e la strada si snoda tra i vigneti della Strada Reale dei Vini e i maneggi – il cavallo è un elemento caratteristico del territorio – per giungere al centro storico e punto panoramico di Mazzè con il suo castello che svetta a dominare il paesaggio. Si scende poi verso la Dora con le ben identificabili balze di origine glaciale per attraversarla con un caratteristico ponte in mattoni rossi dal quale sono visibili gli sbarramenti idroelettrici che caratterizzano il fiume. Attraversando borghi fioriti e laghi “scozzesi” si giunge così al caratteristico borgo di Maglione con i suoi murales per poi rientrare nella pianura con ville in bella posizione sulle colline.
Dopo l’immersione nella natura incontaminata di Candia, siamo pronti per la terza tappa della giornata, che ci conduce verso il millenario Castello di Masino con il suo Parco.
Un raffinato scrigno di storia e arte tutelato e restaurato dal FAI

Il Comune di Caravino è posizionato sulla collina che domina l’abitato e conduce all’affascinante Castello di Masino. Il Castello è una delle più incredibili residenze nobiliari di tutto il Piemonte e meta di grande interesse: mille anni di storia, un parco secolare e tutt’attorno un paesaggio particolarissimo, quello a ridosso della barriera morenica della Serra di Ivrea. Oggi è di proprietà del FAI e se ne possono visitare gli interni, con ampi saloni decorati e arredati con mobili antichi, ambienti di rara e raffinata opulenza.
Prima di entrare all’interno della struttura, merita una visita al grande Parco del Castello che circonda la tenuta, e al suo meraviglioso labirinto settecentesco basato sui disegni originali di archivio del progetto del XVIII secolo. Oggi in stile romantico, più volte rimaneggiato e sistemato all’inglese nell’Ottocento, il parco dà il suo meglio in primavera, quando cascate di fiori di ogni foggia e colore – basti pensare che qui sono stati piantati oltre centodiecimila narcisi e settemila piante di spirea van houttey – lo inondano.
Il castello si presta anche a una visita con i bambini date le varie attrazioni: il labirinto, la torre dei venti, i sotterranei e le numerose attività che vengono proposte ai più piccoli rendono ancora più divertente e avventurosa la gita.
Il percorso prosegue passando da Azeglio, con la residenza già di proprietà di Massimo d’Azeglio e, sullo sfondo, il profilo rettilineo della Serra.
Si giunge così alla gemma azzurra e alla natura incontaminata del Lago di Viverone, quarta e ultima tappa della prima giornata.
Tra relax, sport e natura, in uno scenario UNESCO ricco di storia millenaria

Dopo essere passati da Azeglio, si giunge al lago di Viverone, uno degli specchi d’acqua balneabili più belli d’Italia. Un’oasi felice che offre spiagge, sole, relax, vento per le barche a vela ed è un vero paradiso per l’outdoor, tra sport acquatici e tanti itinerari da percorrere in bicicletta o a piedi intorno alle sue rive. Il lago è anche un’area protetta di interesse naturalistico ed è uno dei sette laghi balneabili della regione.
Il Lago di Viverone ha una storia antichissima testimoniata dalla presenza di un importante sito palafitticolo diventato Patrimonio Unesco e inserito nel sistema dei siti palafitticoli dell’arco alpino, quell’insieme unico di siti archeologici culturalmente ricchi e conservati in maniera eccezionale che raccontano una civiltà plurimillenaria che si sviluppò tra il Neolitico e l’Età del Bronzo.
Durante il giorno, il lago permette di praticare diverse attività sportive e ricreative quali pesca, sci nautico, barca a vela, canoa, windsurf, wakeboard, pedalò, sup e tour su comode imbarcazioni turistiche. Il periplo del lago è lungo una trentina di chilometri ed è facilmente percorribile sia a piedi che in bicicletta su strade, sterrate o asfaltate, ben tenute.
Si conclude in questo straordinario scenario naturale l’ultima tappa della prima giornata in Canavese. Il secondo giorno esploreremo la città di Ivrea.

Lasciando Viverone il panorama spazia dal lago ai versanti della Serra, coltivati a vigne, sui quali si adagiano i centri di Zimone e Piverone in bella posizione soleggiata, per poi raggiungere Palazzo Canavese, che regala una bella vista dall’alto del centro storico dove si ammira un’antica torre campanaria. Attraversando la pianura che si stende ai piedi della Serra si giunge a Bollengo e Burolo. Se si desidera, si può passare da Chiaverano in cui vi è la millenaria chiesa di Santo Stefano di Sessano, oppure da Cascinette d’Ivrea, con la chiesa parrocchiale intitolata a Sant’Antonio da Padova, della seconda metà del XVIII secolo.
Siamo arrivati ad Ivrea, preannunciata in lontananza dalle torri cilindriche del suo trecentesco castello. La Dora Baltea, che conserva molto della vivacità del suo corso anche all’interno dell’abitato, dona a Ivrea un ancor più particolare atmosfera. Ma la cittadina piemontese, capoluogo del Canavese, famosa anche per il suo Carnevale e la battaglia delle arance, merita una passeggiata anche solo per visitarne il cuore industriale legato a Camillo e Adriano Olivetti. Proprio per questo Ivrea è stata riconosciuta Patrimonio Unesco. Ancora oggi gli eporediesi vivono nel ricordo di un’epoca che è stata fondamentale per l’intera storia industriale d’Italia e del mondo. Una città per il lavoro ma anche per i lavoratori-cittadini, per la crescita umana, sociale e culturale delle famiglie e della sua fabbrica intorno alla quale lavorarono i più famosi architetti dell’epoca e si riunirono filosofi, sociologi, letterati per l’elaborazione di un forte pensiero di comunità.
Un viaggio tra vigneti e sapori di confine nel cuore del Nebbiolo

Ultimo centro piemontese al confine con la Valle d’Aosta, dopo la frazione di Cesnola con bel panorama sui vigneti, il grazioso borgo (m 349, ab. 750 circa) porta un nome che deriva da dazio: qui, infatti, si pagava un pedaggio per portare le merci dall’Italia alla Gallia e viceversa. L’abitato dai ripidi vicoli, dalle case con tetti coperti di lastre di pietra dette lòse, con suggestivi archi e i tipici balconi di legno, sorge in un paesaggio circondato da storici terrazzamenti e dà il nome a un vino rosso, a base di uve nebbiolo – proprio come i due principi dell’enologia piemontese, il Barolo e il Barbaresco –, coltivate in buona parte sui vigneti “eroici” aggrappati alla montagna. Il Sentiero dei vigneti, percorso ad anello di circa 4 km con partenza dalla Cantina Produttori del Nebbiolo di Carema, si snoda tra i caratteristici vigneti terrazzati – sistemati sia a pergola che a spalliera – sulle ripide pendici della montagna, su mulattiere e sotto le caratteristiche topie, vigne a pergola sorrette da pilastrini di sasso. Il percorso include anche il borgo di origine medievale, la Gran Masun – una casa-forte di epoca altomedievale che, costruita a scopo difensivo, fu sede della guarnigione locale ma anche antico tribunale e prigione –, la cappella di San Rocco (XVII secolo). “Se qualcuno ha sete venga da me e beva” è l’invito scritto in latino che si coglie anche davanti alla cinquecentesca fontana di via Basilia. Lo zampillo più antico però è quello di San Matteo (1460) vicino alla cappella del Suplin (1649). Non lontano da lì c’è il palazzotto degli Ugoneti, già feudatari di Carema. La chiesa parrocchiale, intitolata a San Martino, risale al 1261 ma è stata rimaneggiata: è dominata dal campanile in pietra (1769) alto 60 metri e unico del genere in Piemonte. Da Carema con suggestive mulattiere si possono raggiungere i ruderi di quello che fu l'imponente castello di Castruzzone (XII secolo), che sorge sopra uno sperone roccioso in frazione Airale, e la frazione di Torredaniele con una bella chiesa da vedere.
Un viaggio tra arte barocca, memorie sabaude e la poesia di Guido Gozzano

Il percorso parte da Ivrea e, nella sua prima parte, attraversa la pianura dell’Eporediese – superando il centro di eccellenza del Bioindustry Park – per poi spostarsi nella seconda parte, superando balze lasciate dall’arretramento dei ghiacciai, nell’Alto Canavese. Passando per Colleretto Giacosa, la cui notorietà si deve a Giuseppe Giacosa, librettista pucciniano autore dei dialoghi della Tosca, della Bohème, di Madama Butterfly, che nacque qui nel 1847, è possibile fare una deviazione in Valchiusella, uno degli angoli più magici di tutto il Canavese, nonché uno dei templi dell’escursionismo canavesano. Da qui è possibile raggiungere Torre Canavese, uno scosceso borgo arroccato in cima a una collina sui cui svettano i resti del ricetto medievale, ha le strade del centro completamente tappezzate da dipinti di artisti di tutto il mondo. Il percorso prosegue arrivando ad Agliè, borgo delizioso circondato da boschi e campagne, con la visita all’affascinante Castello Ducale che è l’esito di varie fasi costruttive sino all’aspetto attuale della residenza voluto dai Savoia: oltre trecento ambienti, il giardino all’italiana, il parco, le fontane e le serre lo caratterizzano

Una volta lasciato il Castello di Agliè, la strada, superato il lago della Gerbola, è circondata da vigneti e cantine con belle viste sui borghi del Canavese. Il filo conduttore dei castelli può poi proseguire a San Giorgio Canavese con quello dei Biandrate per poi arrivare alla vicina Caluso, circondata da un’ordinata e ipnotica selva di vigne, “patria” dell’omonimo vino dai delicati profumi, l’Erbaluce di Caluso, uno dei protagonisti della scena enologica piemontese. L’Erbaluce di Caluso Docg nasce da un antico vitigno autoctono e le sue viti si concentrano oggi tra Caluso, San Giorgio Canavese, Agliè, Piverone e Viverone, a ridosso della collina morenica d’Ivrea. È adatto all’invecchiamento e disponibile in quattro versioni: fermo, spumante metodo classico, passito, passito riserva.
L’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, a Caluso, propone l’enorme patrimonio vinicolo della zona nello storico palazzo appartenuto ai conti Valperga di Masino, nella parte alta del paese, in una piccola piazza che ha mantenuto intatta la suggestione di altri tempi, con un parco di alberi secolari. L’Enoteca offre una completa esperienza di degustazione dei vini del territorio: con oltre 100 m² di spazi espositivi e una vasta sala di degustazione, i visitatori possono conoscere le più importanti etichette dei produttori locali. Un percorso tra le antiche cantine del 1600 ristrutturate guida alla scoperta dei vini tipici delle diverse zone del Canavese arricchito dalla gustosa presenza dei Prodotti Tipici della Provincia.