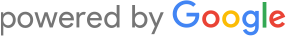I capolavori dei borghi più belli d'Italia
4 minuti

Indice
Tanti piccoli musei, chiese, palazzi dei borghi conservano tesori che pochi conoscono, perché per vederli bisogna andare sul posto, spesso remoto o mal collegato. Si dice che l’Italia sia un museo diffuso, ed è vero. Infatti anche i piccoli centri conservano capolavori assoluti dei più grandi artisti. Nei Borghi più belli d’Italia si trovano opere di Giotto, Simone Martini, Antonello da Messina, Mantegna, Raffaello, Perugino, Pinturicchio, Parmigianino, Paolo Veronese, Canova … Tra le moltissime opere che ci aspettano nei borghi ve ne segnaliamo cinque tra la Lombardia e la Sicilia.
Lovere (Brescia) – Tommaso Pombioli, Suonatore di chitarra, 1636, Accademia Tadini.

Cominciamo con un dipinto che, a differenza delle altre quattro opere, non è proprio un capolavoro, ma ci piace molto. Siamo a Lovere sul lago d’Iseo, in provincia di Brescia. Qui ha sede uno dei musei più importanti del Nord Italia, l’Accademia Tadini, che ha origine dall’Istituto di belle arti fondato dal conte Luigi Tadini nel 1829. Le collezioni del museo spaziano dalle porcellane ai dipinti di diverse epoche storiche, con particolare riguardo alla pittura lombarda e veneziana tra Sei e Ottocento. Grandi nomi come Canova, Bellini, Paris Bordon, il Pitocchetto. Ma ci ha intrigato anche il Suonatore di chitarra dipinto da Tommaso Pombioli nel 1636: una via di mezzo tra Jimmy Page dei Led Zeppelin e un damerino tutto agghindato. Il protagonista della scena - che imbraccia una chitarra e ha un liuto poggiato sul tavolo – è un pittore, Giacomo Barbelli, che si diletta di musica, e lo fa con aria trasognata. Morì per un colpo d’archibugio durante una battuta di caccia.
Citerna (Perugia) – Donatello, Madonna con Bambino, 1415-1420, chiesa di San Francesco.

Andiamo ora a Citerna, piccolo borgo umbro affacciato sulla valle del Tevere, al confine con la Toscana. Qui, nella chiesa di San Francesco, è custodita la splendida scultura della Madonna con Bambino attribuita, con ormai quasi assoluta certezza, al giovane Donatello. L’opera è datata tra il 1415 e il 1420. La Madonna è una ragazza: rivela la grazia delle fanciulle fiorentine che lo stile del gotico internazionale rappresentava come pallide, esangui, riccamente abbigliate con ori, argenti e lacche. Nell’autunno del Medioevo, a Firenze, questa immagine fiabesca della donna, alimentata nelle corti del tempo, sta per cedere il passo alla rivoluzione umanistica. E la Madonna-ragazza di Donatello ha già la tenerezza e l’umanità richieste dal nuovo clima culturale.
Irsina (Matera) – Andrea Mantegna, Sant’Eufemia, 1450 ca., cattedrale.

Torniamo al fascino femminile con un altro capolavoro. Lo firma uno dei maestri del Rinascimento, Andrea Mantegna, ed è una scultura realizzata con la pietra gialla di Vicenza, le cui colorazioni vanno dal beige e dall’avorio al dorato chiaro. Arrivata nella remota Lucania nel 1454 grazie a Roberto De Mabilia che la acquistò nella bottega del grande artista padovano, la statua di Sant’Eufemia si ammira nella cattedrale di Irsina. È davvero stupenda: alta 172 centimetri, rappresenta la martire con una mano nelle fauci del leone, a ricordo del martirio subito, mentre l’altra regge un monte a tre cime con un castello che simboleggia Irsina. Lo sguardo è fiero, espressivo, più da nobildonna che da santa, e le mani affusolate, bellissime, plasmate così bene nella pietra – come tutta la figura, del resto – come solo un gigante dell’arte sa fare. Sta a noi decifrare cosa comunica uno sguardo così potente.
Cefalù (Palermo) – Antonello da Messina, Ritratto di uomo (o Ignoto marinaio), 1460-1470, Museo Mandralisca

Chiudiamo il giro tornando all’universo maschile, con un’altra opera straordinaria e con un altro sguardo. Molti vengono a Cefalù, in Sicilia, per tre cose: il mare, la cattedrale normanna e lui, l’“ignoto marinaio” dipinto tra il 1460 e il 1470 da Antonello da Messina e conservato al Museo Mandralisca. La piccola tavola, che si dice fosse utilizzata come sportello in un mobile da farmacia, fu donata al barone Mandralisca di Cefalù ed è per questo che si trova qui. C’è chi sostiene che il marinaio siciliano o chi per lui (secondo il critico Roberto Longhi sarebbe un notabile del luogo) rappresenti l’equivalente maschile della Gioconda di Leonardo. Non solo è enigmatico, lo sguardo, ma anche provocatorio, al limite dello strafottente. Per Vittorio Sgarbi “è l’emblema della Sicilia, con la sua furbizia, astuzia, abilità”. Una quindicina di strisciate che sono state restaurate, proverebbero che qualcuno, forse una donna, si sia sentito offeso da quello sguardo e avrebbe reagito danneggiando l’effige. Mistero: ma è certo che, dopo averlo visto, nessuno si scorda più il piccolo quadro di Antonello da Messina.
Sutri (Viterbo) – Efebo, I secolo d.C., Museo di Palazzo Doebbing

Guardiamo ora la bellezza dalla parte maschile. Un altro capolavoro che ci regala la provincia italiana è, sempre nel centro della Penisola, a Sutri, nel Lazio, una statua in bronzo del I secolo d.C. alta 78 centimetri. L’Efebo di Sutri è un giovane uomo nudo e in posizione eretta, con la mano destra appoggiata alla testa e il braccio sinistro piegato come per portare qualcosa (ora mancante) all’altezza del viso, probabilmente uno specchio. Un ragazzo narciso, che si compiace di sé, in posa perenne nel museo di Palazzo Doebbing. La piccola statua, ritrovata a Sutri da due contadini nel 1912, è diventata il simbolo stesso del borgo viterbese.