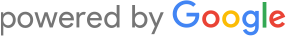Alla scoperta dei luoghi della fede nei borghi più belli d'Italia – Parte II
5 minuti

Proseguiamo il nostro viaggio nei borghi della fede: quelli in cui si respira il sacro, nelle tracce consumate dal tempo, nella luce che spiove dalla vetrata di una chiesa o nella penombra di un convento. In questi posti ci si sente felicemente “inattuali”, perché le urgenze delle cose da fare, la fretta, il lavoro, l’ansia, si placano davanti a considerazioni di più vasto respiro. Si resta, infatti, sorpresi dalla tenacia con cui le generazioni precedenti, nei secoli lontani, si sono aggrappate alla trascendenza, sacrificando la loro vita nella cella di un monastero o semplicemente credendo nei miracoli.
I ritmi rallentano, e appena fuori Milano si entra in un’altra dimensione, se si ha per meta l’abbazia cistercense di Morimondo. Si entra in un paesaggio di acque – il Ticino, le rogge, i canali -, di prati, boschi, cascine e risaie, che ha ricevuto la sua vocazione agricola dai monaci venuti dalla Francia quasi novecento anni fa.
Si riflette poi sull’orrore del femminicidio ripercorrendo a Corinaldo, nella Marca anconetana, i luoghi di Maria Goretti, la santa bambina uccisa nel tentativo di sfuggire al suo violentatore.
Subiaco, nel Lazio, poco distante da Roma, è invece la “soglia del Paradiso”, come Petrarca definì il monastero di San Benedetto, addossato alla roccia, in uno splendido scenario naturale.
Infine a Stilo, in Calabria, la Cattolica – il tempio bizantino meglio conservato in Italia – sembra veramente provenire da un altro mondo: quello dei monaci basiliani giunti da Oriente, che salmodiavano in greco e mormoravano preghiere tra le candele e l’odore d’incenso. Povertà, digiuno, assenza, ascesi, distacco dalle cose mondane, erano i loro ideali.
Non solo bellezze architettoniche, paesaggi da ammirare e specialità gastronomiche: nei borghi si va anche per ritrovare il sacro e riflettere sul senso della vita.
Morimondo (Milano) – L’abbazia cistercense

Nel 1134, quasi nove secoli fa, arrivarono nella valle del Ticino dodici monaci provenienti da Morimond, in Borgogna, una delle quattro abbazie-madri da cui i cistercensi partivano per fondare altre abbazie in tutta Europa. Due anni dopo, i monaci iniziarono la costruzione della nuova abbazia, che chiamarono Santa Maria di Morimondo. Vestiti di lana bianca grezza di pecora, si occupavano direttamente delle attività agricole, disboscavano, bonificavano e irrigavano l’area intorno al fiume Ticino, trasformandola in zona fertile con coltivazioni a marcite. Preghiera, lavoro e studio: nel giro di due secoli l’abbazia di Morimondo arrivò a possedere terre coltivate, boschi, grange, mulini e cascine, ed è grazie agli antichi monaci che in quest’area della Lombardia si è sviluppata l’agricoltura più avanzata d’Italia. La chiesa abbaziale riflette i caratteri dell’architettura monastica, priva di fronzoli, dove il senso di ordine è dato dai mattoni a vista. Tutt’intorno, filari di pioppi, canali d’irrigazione, aziende agricole, opere idrauliche, zone umide: la quieta bellezza del Parco del Ticino.
Corinaldo (Ancona) - I luoghi di Maria Goretti

“No, no, Dio non vuole, se fai questo vai all’inferno!”: è con queste parole che una bambina di dodici anni, nata a Corinaldo nel 1890, cercò di difendersi dal suo aggressore. Colpita ripetutamente con un punteruolo, morì il giorno dopo perdonando il ventenne assassino. Nel 1950 Maria Goretti fu canonizzata. A un chilometro e mezzo dal paese si trova la sua casa, una piccola abitazione contadina. Il santuario di Santa Maria Goretti, posto nella parte più alta del centro storico, è una costruzione di metà Settecento con uno svettante campanile. Ma le vicende della santa bambina non sono l’unico motivo per venire a Corinaldo. Il borgo è bellissimo, grazie al colore caldo del mattone che lo avvolge come una pelle. Due cerchie murarie - quella del 1367 e quella più grande del 1480 – lo hanno difeso egregiamente nei secoli. Mura inviolate, con tante torri: un set perfetto per un film in costume. E poi una bellissima scalinata, chiamata la Piaggia, di 109 gradini, verso cui convergono le case in mattoni rossi disposte a spina di pesce. A metà, c’è il Pozzo della Polenta dove, secondo la leggenda, gli abitanti cucinavano la polenta durante gli assedi.
Subiaco (Roma) - I monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica

Dei tredici monasteri fondati da San Benedetto da Norcia nella valle dell’Aniene, l’unico sopravvissuto è quello di Santa Scolastica, la sua sorella gemella. Il cenobio sorge sul luogo del primitivo oratorio del VI secolo. All’interno del monastero si trova la Biblioteca Nazionale in cui sono custoditi manoscritti, pergamene e i primi incunaboli, impressi da due tipografi tedeschi nel 1465. Il più antico monastero benedettino al mondo è dunque anche la culla della stampa in Italia. La visione del monastero di San Benedetto illuminato nella notte stellata dell’Aniene è quasi mistica, non lascia indifferenti. Fu costruito per custodire la grotta – il Sacro Speco - che accolse le solitudini di Benedetto nei tre anni in cui visse da eremita. Da lì si accese la fiaccola del monachesimo benedettino, che illuminò per secoli la cultura europea. Nel 1223 San Francesco venne in visita al Sacro Speco. Gli fu donata una piccola cappella sulla quale, in seguito, fu costruito il convento ancora esistente. Nella chiesa si ammirano gli affreschi della cerchia del Sodoma e della scuola del Pinturicchio.
Stilo (Reggio Calabria) – La Cattolica

Stilo è la Città del Sole: non tanto per il radioso volto mediterraneo che il borgo calabrese incarna, quanto, piuttosto, per aver dato i natali nel 1568 a Tommaso Campanella, il filosofo che pagò con trent’anni di carcere la libertà di pensiero e scrisse uno dei testi più importanti del Seicento, La città del sole. Ma il sole è anche la luce che emana da uno dei monumenti bizantini meglio conservati in Italia, la Cattolica, risalente al IX secolo. È un tempietto a forma di cubo e a croce greca, con tre absidi rivolte a Oriente e cinque cupolette. Qui i monaci basiliani, che in Calabria avevano trovato rifugio dalle persecuzioni, mettevano in pratica il loro ideale di povertà e distacco dal mondo. Entrati nel piccolo ambiente, ci sente subito avvolti da un senso di serenità: merito, forse, della luce che nella parte superiore è fulgida, brillante, e nella parte bassa è fievole, in modo da favorire il raccoglimento. Le quattro colonne vengono forse dalle rovine dell’antica colonia greca di Kaulon, e sembra incredibile che in un così piccolo spazio sia concentrata tanta storia dell’umanità. È una delle molte sorprese che capitano a chi viaggia per borghi.