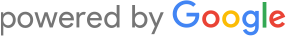Famosa per arte, monumenti e statue, l’Italia è ricca di tesori straordinari. Dal Colosseo alla Torre di Pisa, sono molte le opere da ammirare. Passeggia per le città, visita i musei e lasciati incantare da statue imponenti, edifici storici, fontane e altri capolavori dell’architettura italiana.