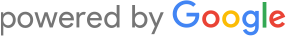Aerei sul fondo. Un patrimonio da proteggere
5 minuti

Un relitto è spesso un sito eccezionale per un’immersione subacquea, ma anche la testimonianza sul fondale di un tragico naufragio, spesso con un costo carissimo in termini di vite umane. L’approccio verso questo tipo di patrimonio finisce perciò per cambiare spesso anche in rapporto all’antichità del naufragio stesso: le vittime di una tragedia navale recente richiedono un rispetto e un’attenzione particolari, per forza di cose diversi da quelli che riserveremmo a una nave, affondata migliaia di anni fa in circostanze che non conosceremo mai, con il suo per noi oscuro equipaggio.
Lo stesso si può dire, e acquista forse maggiore significato, anche per i numerosi relitti di aerei: fusoliere, ali, eliche e motori sul fondo del mare costituicono siti di immersione straordinari, ma allo stesso tempo contesti dolorosi, che raccontano voli spezzati, e velivoli precipitati dal cielo alle onde, spesso nel corso di azioni di guerra. Ovviamente, la breve storia dell’aviazione civile e militare rende praticamente ogni velivolo un relitto recente, una tragedia vicina, un evento che ha lasciato ferite profonde in individui a noi prossimi, i cui discendenti sono ancora tra noi.
Anche gli aerei inabissati, al pari dei relitti navali, d’altronde, fanno parte del nostro patrimonio comune, anche se a volte non vengono percepiti dai sub come tali, e finiscono per essere preda di saccheggi e danneggiamenti. Non c’è da stupirsi, perciò, se i relitti di aerei meglio conservati sono quelli ad alta profondità, relativi a velivoli precipitati nel mare aperto: in questi suggestivi contesti, persi nel blu, la natura spesso esplode con eccezionale vigore, colonizzando gli strumenti di bordo, i seggiolini, le lamiere contorte, e riportando la vita in luoghi di morte.
Valorizzare questa categoria di siti è una vera sfida: occorre rispettare la memoria dei caduti senza trascurare il valore storico dei velivoli, ma al tempo stesso rendere possibile la conservazione e la fruizione. Di conservazione in situ si parla ancora poco: soprattutto per i mezzi militari, le flotte aeree moderne spesso propendono per il recupero e la musealizzazione: il Museo dell’Aeronautica Militare Italiana a Pian delle Orme è, in questo senso, un esempio chiarissimo e non pochi aerei, nei suoi hangar, provengono dal fondo del mare.
Il Reggiane 2000 di Riomaggiore

Uno dei relitti di aerei più interessanti scoperti negli ultimi anni non è tecnicamente un sito subacqueo: scoperto nel 2012 nell’AMP delle Cinque Terre, è stato recuperato nel 2013 dall’Aeronautica Militare per essere poi restaurato ed esposto nel Museo Storico di Vigna di Valle. Si tratta di un velivolo speciale: un piccolo monomotore da caccia che veniva imbarcato sulle navi militari della Regia Marina e letteralmente catapultato in volo, per le sue missioni. Il ritorno doveva avvenire su una normale pista d’aviazione, ma in questo modo si riusciva a imbarcare un velivolo, o una coppia di velivoli, su una nave normale e non su un vero e proprio, costosissimo, aeroporto galleggiante come una portaerei. Esistono soltanto altri due esemplari al mondo di questo gioiello dell’ingegneria aeronautica italiana.
L’esemplare precipitato tra Riomaggiore e Portovenere era pilotato dal Maresciallo Luigi Guerrieri, che, nel corso di un’esercitazione, il 16 aprile del 1943, si ritrovò senza carburante e optò per un ammaraggio di emergenza. Il velivolo si inabissò rapidamente, ma il pilota venne tratto in salvo, e, superata la fine della guerra, perì nel 1946, in un volo di addestramento su un caccia statunitense.
Il Bristol Beaufighter di Linosa

Nell’AMP delle Isole Pelagie, al largo dell’isola di Linosa, nel corso della Seconda Guerra Mondiale il cielo era continuamente solcato da aerei militari: l’arcipelago siciliano, al centro del Mediterraneo, vedeva continue operazioni e non di rado alcuni aerei finivano per precipitare in mare.
Il Bristol Beaufighter di Linosa, un cacciabombardiere bimotore largamente utilizzato nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, si trova oggi a circa 70 metri di profondità, in cattivo stato di conservazione: ali e timoni sono ormai perduti, ma la lunga fusoliera e i due grandi motori radiali da 1600 cavalli sono ancora riconoscibili, sotto la pesante copertura di conchiglie e organismi marini.
Raggiungere il relitto è impegnativo ma possibile, a patto di essere in possesso di brevetti e competenze per una profondità ben oltre i limiti della subacquea sportiva. Lo sforzo è comunque ripagato dalla possibilità di vivere un’esperienza davvero unica, incontrando una complessa macchina volante nell’oscurità di un fondale marino profondo.
Il Martin Baltimore di Linosa

Rinvenuto nel 2016, il Martin Baltimore di Linosa è un altro velivolo precipitato nelle acque dell’AMP delle Isole Pelagie, nel corso delle concitate fasi della Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico, l’aereo, appartenente al 69° squadrone aereo della RAF, era decollato dall’isola di Malta alle 12.45 del 15 giugno 1942 per osservare le navi coinvolte nella cosiddetta Battaglia di Mezzo Giugno. Colpito da fuoco nemico, il velivolo riuscì a planare dolcemente e ad ammarare, a motori spenti, per poi posarsi su un fondale a oltre 80 metri di profondità.
In questo modo, il relitto si è mantenuto in maniera eccezionale, e costituisce oggi il velivolo meglio conservato sui fondali di Sicilia. Si tratta peraltro di un modello di aeromobile ormai rarissimo: esistono al mondo solo pochissimi altri Martin Baltimore, e tutti frammentari. Non è il primo caso in cui si scopre in un abisso marino ciò che ormai non è più esistente sulla terraferma. Gli aerei giunti serenamente a fine vita e condannati alla radiazione vengono solitamente smantellati per recuperare metallo e altri materiali, un po’ come con le navi che, ormai alla fine delle loro lunghe navigazioni intorno al mondo finiscono nei grandi cantieri di disarmo in Asia, dove vengono smontate un pezzo dopo l’altro.
Il Falco di Tavolara

Poco a sud dell’isola di Tavolara, nei pressi dell’isola di Molara, a 36 metri di profondità è ancora visibile un relitto aeronautico di grande fascino. Si tratta di un monomotore militare di fabbricazione italiana, quasi certamente un Reggiane 2001, noto come Falco II ed evoluzione del precedente Reggiane 2000.
Costruito in appena 237 esemplari dalla Caproni-Reggiane, il Falco volò a lungo sul Mediterraneo, grazie a ottime doti di velocità e maneggevolezza, garantite dal design avanzato per l’epoca e dal potente motore Alfa Romeo da 1175 cavalli.
Il Falco di Tavolara non è stato ancora identificato con certezza, ma sembra precipitato in mare dopo la guerra, dal momento che gli pneumatici Pirelli ancora montati ai carrelli appartengono a un tipo prodotto solo a partire dal 1946.